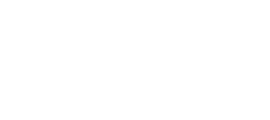Una mattina, siccome uno di noi era senza nero, si servì del blu: era nato l'impressionismo.
(Pierre-Auguste Renoir) |
| Blu Kline |
 |
| Kazmir Malevich - Quadrato Rosso |
Potremmo attribuire al colore una valenza esclusivamente espressiva e, a dispetto di tutte le teorie elaborate, in effetti non c'è nulla di meno oggettivo. Lo "spettro elettromagnetico" così come è stato elaborato, è percepibile solo dall'occhio umano, e non ha una valenza unifirmabile per tutti. Sappiamo bene che le onde elettromagnetiche visibili sono un brevissimo intervallo delle frequenze possibili conosciute, quelle abbiamo dato un nome nella scala dei colori, ma nella realtà esse hanno un'ampiezza e un "colore" superiori. Riflettere sulla natura del colore quindi, ci aiuta a renderci conto dell'approssimazione delle idee, spesso ingiustificate, che abbiamo. Quando ad esempio diciamo che un albero è verde, dovremmo prestare più attenzione alle parole che usiamo. I corpi, le cose, ci appaiono grazie al fatto che la luce, investendo un corpo, ne viene in parte assorbita e in parte riflessa, e quello che noi vediamo, il colore risultante dalle onde luminose riflesse, è appunto quello che in genere definiamo il colore di quell'oggetto. Ma volendo essere precisi, l'oggetto in sè non è di quel colore. Per quanto ne sappiamo, anche dando per scontato che il nostro occhio sia "obbiettivo", se vediamo un verde, ben che vada quel corpo potrebbe essere il colore o la somma delle onde elettromagnetiche assorbite, ovvero il colore complementare a quello che noi vediamo, cioè rosso. Ma anche di questo non sarei così sicuro.
 |
| Spettro Elettromagnetico |
Dalle teorie sulla luce e sul colore, elaborate da Newton, da W. Goethe e sistemizzate in seguito da J. Itten al Bauhaus, ne sono derivati essenzialmente due sistemi di composizione dei colori. Uno basato sulla percezione e la composizione dei colori riflessi, e utilizzato anche dagli impressionisti, caratterizzerà i metodi di stampa: CMYK - (Cyan Magenta Yellow e K). Questo sistema, conosciuto come quadricomia o "sintesi sottrattiva" presuppone che la mescolanza di due dei colori primari (es. Cyan e Yellow), diano luogo ad un colore secondario (Green), generando quindi una ulteriore sequenza di tre colori secondari, Red, Green, Blue, che vanno a formare coppie di colori complementari (Green/Magenta, Red/Cyan, Blue/Yellow). Ed infine, la presenza/mescolanza contemporanea dei tre colori secondari genererebbe il K (nero). M questo in realtà non succede. Quando si mescolano i tre colori secondari si ottiene un marrone scuro e per questo motivo il K (nero) viene aggiunto separatamente, ottenendo così la Quadricromia (CMYK).
L'altro invece, detto di "sintesi additiva", utilizzato dagli schermi video, è composto dai colori RGB (Red, Green, Blu) e ha come caratteristica principale il fatto che si avvale di sorgenti luminose. Di conseguenza, quando utilizziamo uno schermo RGB per visualizzare le immagini, è importantissimo considerare che i colori sono relativi al questo sistema, e che non corrisponderanno mai a quelli che eventualmente andremo ad ottenere in stampa. La discrepanza può essere notevole, e anche nel caso in cui il monitor che stiamo utilizzando sia "calibrato" (cosa già eccezionale di per sé), il risultato finale sarà la maggior parte delle volte deludente. I due sistemi, apparentemente intercambiabili e appartenenti allo stesso mondo dell'espressione visiva, sono in realtà due mondi incomunicanti. La luce riflessa dai pigmenti e la luce sorgente dei monitor o di lampade colorate e/o filtrate, si comportano in modi assolutamente autonomi e sorprendentemente contrastanti. Credo sia importante considerare che oggi, la maggior parte delle tecnologie che utilizziamo per progettare, utilizza il sistema RGB, e avere delle conoscenze, anche tecniche, di come sono costituiti gli schermi in uso, possa aiutarci ad utilizzarle con cognizione di causa. Ad esmpio, quando dobbiamo stampare dei colori, siano essi delle foto o delle composizioni grafiche, è importante tenere presente esse andranno convertite in CMYK.

Queste due bandiere, molto simili tra loro, ma assolutamente non uguali, utilizzano, con due scopi diversi, il contenuto della figura retorica dell'arcobaleno: Il senso comune della diversità, della varietà "naturale" degli elementi e della loro "meraviglia". Ma, a ben vedere, a mio avviso, nessuna delle due ha una stretta rilevanza con il messaggio che vorrebbe veicolare. Il caso già citato della mela colorata di Macintosh, era molto più specifico e circostanziato, alludeva appunto alla varietà dei colori nella creatività e nell'arte. In queste due bandiere invece, il rimando mi pare molto più flebile, legato più ad un sentire comune ed a una diffusione nei media e nell'uso, che ad una specificità di contenuto e di linguaggio. Il messaggio "funziona" più in relazione alla sua diffusione e alla sua reiterazione che ad una specificità intrinseca.
 |
| Restyling Logo |
In quel periodo e sull'onda degli avvenimenti che avevano riproposto l'utilizzo del codice visivo ed il pattern dell'arcobaleno, avevo provato ad utilizzarlo per Greenpeace. A ormai trent'anni dalla sua fondazione, si presentava l'opportunità di realizzare un "restyling" del logo, che avrebbe potuto rappresentarne un rilancio, anche nei contenuti. Un passo indietro: Greenpeace è prima di tutto un "Logos" un'idea, un concetto nuovo: Green Peace (Pace verde) che letteralmente, non significa nulla. Il nome nacque allorquando la nuova associazione, si pose il problema della propria identità e della propaganda dei nuovi contenuti ed istanze rispetto alla salvaguardia dell'ambiente. La ricerca e l'individuazione di un Logos, e quindi di una forma di comunicazione conseguente, per questa organizzazione nata negli anni "70, era ed è consapevolmente sentito. Le alternative sul tavolo, erano prevalentemente due: RainbowWarriors e GreenPeace. La prima si rifaceva alla cultura dei Nativi americani, allora molto in voga, e ad una idea di cambiamento che definiremmo attivo. L'altra invece al nascente movimento dei Verdi, che stava affermandosi in tutta Europa, per la salvaguardia dell'ambiente. Un'altro punto fermo della seconda ipotesi si rapportava all'ideale di cambiamento, così come era stato espresso da Gandhi cioè come non violenza e disobbedienza civile. Alla fine, Greenpeace adottò il simbolo dell'arcobaleno su una sua nave, il Rainbow Warrior, appunto, ma la congiunzione "astratta" ed elementare dei termini Verde e Pace, parvero più consoni ai contenuti prevalenti dei fondatori, con l'ulteriore caratteristica di generare una parola nuova, un Logotipo indiscutibilmente originale e riconoscibile, (scritto a mano). Dal mio punto di vista, la diffusione e affermazione della associazione, poteva rappresentare un buon momento per rivendicare, da una parte una sorta di imprimatur dell'elemento dell'arcobaleno, dall'altra rilanciarne l'immagine in un restyling che lasciava quasi inalterato il logo precedente e recuperava invece altri contenuti che erano tornati in auge.
| Logotipo |
Un simpatico e intelligente esempio delle possibilità del colore di diventare comunicazione e/o identità, evidenziando al contempo i contenuti, è stata la tesi di due studentesse per un logo e una campagna che aveva come scopo quello di favorire l'integrazione delle manifatture cinesi in Italia, che in quel momento erano più vissute come un problema sociale che un'opportunità. Attraverso la riformulazione della dicitura commerciale "Made in" Chinatown, arrivarono ad una ridefinizione creativa che la ampliò facendola diventare comunicazione. Graficamente, il felice e significativo concetto proposto, si trasformò in un simpatico, ed allora innovativo esempio di comunicazione istituzionale, capace di individuare e coniugare logo, logotipo, colore, comunicazione e payoff, in pochi sintetici elementi, interconnessi.
 |
| Doppia Pagina Istituzionale - Manifesto |
 |
| Logo |
In particolare, anche in questo caso il colore che ironicamente allude alla razza, viene trasformato in contenuto, in valore positivo. La campagna, caratterizzata da una estrema semplicità diventa agevolmente declinabile in molteplici forme e mezzi. In definitiva, una volta individuati gli elementi fondamentali della comunicazione: colore, segno e payoff, il tutto diventa estremamente facile e divertente. Tra le altre cose non posso fare a meno di notare quanto questa campagna, (tutt'altro che semplice nell'analisi della situazione politica e sociale e delle ragioni della sua situazione storica) ideata e realizzata ormai diversi anni or sono, fosse premonitrice degli sviluppi futuri e di un diverso rapporto ormai consolidato con le economie orientali.
Un altro esempio significativo delle capacità forti e sintetiche del colore di essere comunicazione. si realizzò quando nel 2000, fù liberalizzato il mercato della telefonia. Benetton e altri soci, lanciarono un loro operatore che venne chiamato BLU. Tre lettere e una comunicazione semplice e in quell'ambito con una sua forza ed un suo perchè evidente. Blu passò in pochi mesi da 400 mila a un Milione e passa di utenti, registrando una performance che nessuna azienda di quel settore aveva mai avuto prima. A mio parere però l'operazione fù un po ridondante. Credo che sarebbe stato sufficiente il logotipo "BLU" (pare suggerito da Cossiga) realizzato in un carattere disegnato appositamente. Tutto il resto, il logo (una specie di strano uovo che richiama un po la Barilla), il Payoff, e soprattutto la campagna di comunicazione (copiata da quella che pochi anni prima avevo realizzato sempre per il gruppo Benetton SportSystem) li considero incongruenti. Il tutto andò a carte e quarantotto, allorquando il governo mise in vendita le frequenze telefoniche a prezzi esorbitanti e diversi operatori recesero dalla gara, ritirando i loro investimenti.
Un'altra esperienza circa le capacità comunicative del colore è quella del logo scelto in seconda battuta, per l'EXPO 2015 di Milano, che però nella sua apparente semplicità, rivela una scelta quantomeno problematica, che già nella progettazione genera problemi compositivi di utilizzo e di conseguenza di contenuti.

La scelta di utilizzare i colori primari della sintesi sottrattiva, due caratteri diversi (ancora la E del logo Esprit), rimanda ad un mondo Pop largamente esplorato dalle Agenzie e dai grafici degli anni "60 strettamente connesso ai mezzi di comunicazione analogici e alle tecniche di stampa litografiche. La sintesi sottrattiva CMYK ha seri problemi di corrispondenza e di riproduzione sugli schermi delle device attualmente in uso (che utilizzano invece il "sistema additivo" RGB) a led o cristalli liquidi. Inoltre la logica strutturale della costruzione del marchio, è costretta, al fine di renderne la leggibilità, ad abdicare, introducendo un viola e un nero che, specie nella O, non avrebbe alcuna ragion d'essere. Questo tipo di approccio approssimativo nella costruzione di un marchio, a mio parere slegato da una finalità comunicativa, ma esclusivamente estetica, è destinato a creare problemi di contenuto e di utilizzo. Credo che in questi casi, una rigorosa semplicità coerente, alla fine, possa portare a soluzioni più originali e gestibili, specie in riferimento agli innumerevoli mezzi e materiali di comunicazione che verranno utilizzati.
 Ma anche sorvolando sui
problemi tecnici e considerando invece le implicazioni in merito ai contenuti, se possiamo cioè attribuire a questo tipo di utilizzo del colore,
un rimando alla varietà dei paesi coinvolti in una manifestazione del
genere, non se ne vede, a mio parere, il legame con il contenuto sociale
di lotta alla fame e all'energia per il futuro, che semmai potrebbe essere
identificata con la luce come sorgente e non riflessa. Non che il logo
precedentemente elaborato fosse una meraviglia. Nella sua complicazione
cacofonica, aveva almeno il merito di essere orribilmente originale e
immediatamente riconoscibile nei contenuti e nei riferimenti. Forse il problema sta proprio nella natura di
manifestazioni di questo tipo, che rischiano di cozzare con i contenuti
che si sono dati.
Ma anche sorvolando sui
problemi tecnici e considerando invece le implicazioni in merito ai contenuti, se possiamo cioè attribuire a questo tipo di utilizzo del colore,
un rimando alla varietà dei paesi coinvolti in una manifestazione del
genere, non se ne vede, a mio parere, il legame con il contenuto sociale
di lotta alla fame e all'energia per il futuro, che semmai potrebbe essere
identificata con la luce come sorgente e non riflessa. Non che il logo
precedentemente elaborato fosse una meraviglia. Nella sua complicazione
cacofonica, aveva almeno il merito di essere orribilmente originale e
immediatamente riconoscibile nei contenuti e nei riferimenti. Forse il problema sta proprio nella natura di
manifestazioni di questo tipo, che rischiano di cozzare con i contenuti
che si sono dati. Sound
Le interazioni espressive tra suono e colore, sono molto interessanti e sono state ampiamente indagate da artisti e movimenti dell'arte contemporanea. Una recente dell'utilizzo del colore quale elemento fondamentale della comunicazione, è stata quella che ha portato all'ideazione e alla realizzazione di un logo generativo per una scuola di musica. In una prima fase, sono state realizzate numerose proposte interessanti ma con un approccio abbastanza "convenzionale". In seguito, sono pervenuto alla convinzione che in questo caso, data la particolarità del committente, sarebbe stato interessante indagarne anche la dimensione temporale, caratteristica della musica. Un suono, non è l'inizio o la fine di una composizione, ma dobbiamo considerarlo come un elemento che viene dal silenzio che lo precede e nel quale, (se non sostenuta), è destinato a ritornare. Suono e silenzio, mi appaiono più come accade nella scala cromatica dei colori, ove le radiazioni visibili al nostro occhio, sono una parte delle radiazioni possibili.
 |
| Farbcreis - Joannes Itten |
Già V. Kandinskij che era a conoscenza della teoria del colore di Itten, col quale aveva insegnato al Bauhaus, nello "Spirituale nell'Arte" e in una serie di opere denominate "composizioni" si era occupato della funzione emotiva ed espressiva del colore ed in particolare della relazione tra la musica, i suoni e la loro rappresentazione formale.
 |
| Vassily Kandinsky - Composizione |
Influenzato dalla teoria di Aleksandr Skrjabin e dalla sua scala tonale del circolo delle quinte, si applicò ad una serie di opere astratte che presupponevano una stretta relazione compositiva ed espressiva tra il colore e la musica.
 |
| Sequenza dei colori nella scala tonale. |
 |
| I colori della tastiera di Skrjabin. |
Dal punto di vista formale, la scala tonale del circolo delle quinte di Skrjabin è un dodecagono, che permette di costruire una figura geometrica dodecaedrica stellare, in grado di espandere la scala tonale nello spazio tridimensionale. In sostanza, questa configurazione, si presta ad assumerne una funzione strutturale utile alla costruzione del logo, e a stabilire ed identificare precisamente quella "misura" che stavo cercando.
Definita la struttura fondamentale della composizione, (quella che soggiace e funge da ordine e scansione spaziale) e sovrapposta alla scala di Skrjabin, o a quella di Itten, risulta evidente che si è raggiunta quella "macchina compositiva" che, tradotta in accordi, è in grado di generare immagini sempre diverse, ma al contempo sempre riconoscibili in quel dato sistema visivo, compositivo e formale, che può assurgere alla funzione di Logos. Infatti, scelta una qualsivoglia sequenza di accordi, si ottiene un'immagine che nel contempo permette, mutando la sequenza, di generarne altre, sempre diverse ma sempre riconoscibili come facenti parte di un determinato "sistema visivo di comunicazione".
Qui di seguito, alcuni esempi creati dagli studenti, che mostrano le varie ed infinite possibilità di questo sistema. Esistono certamente delle variabili indipendenti da decidere al momento della scelta dello "stile" da adottare, ma "la macchina", il sistema è definito da una funzione matematica e non dà scampo.
Credo che in questo caso, sia importante sottolineare il fatto che nella ricerca e nella progettazione di questo logo, ci si è dovuti spogliare di molte idee precostituite su cosa debba essere convenzionalmente un logotipo. La creatività deve in ogni momento confrontarsi con le regole, le conoscenze acquisite e l'oggetto della ricerca. Spesso, ciò che si sa, che si conosce e che serve a guidarci deve essere messo coraggiosamente in discussione, alla ricerca di un ordine, di una misura nuova strettamente connessa e giustificata, dall'oggetto della ricerca. Il rischio principale è quello di non vederne le conseguenze ed i risultati innovativi, o quantomeno di realizzare fiacchi risultati poco interessanti e per nulla soddisfacenti le ambizioni iniziali. Infine è importante sottolineare che il processo, data la stretta relazione tra l'aspetto visivo e musicale, è assolutamente reversibile e potrebbe permettere, attraverso lo sviluppo di applicazioni derivate, ove l'identificazione e l'associazione del colore con le note, permette un facile approccio all'insegnamento della musica stessa.
Uno studio appassionato sulle relazioni esistenti tra suono e colore e sulle loro caratteristiche compositive, è quello condotto da Luigi Veronesi e pubblicato da Siemens Data nel 1977, di cui riporto uno dei significativi risultati.